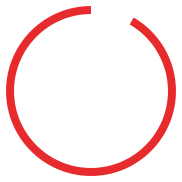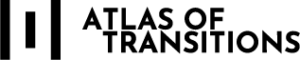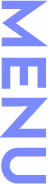Sui miti urbani, il suono come rappresentazione creativa, e il desiderio di capirsi. Intervistando ZimmerFrei
Parte della vostra riflessione artistica è ispirata dal lavoro di Francis Alÿs, un artista belga, messicano d’elezione, che in occasione della performance collettiva ‘When Faith Moves Mountains’ [Quando la fede sposta le montagne], nel 2002, ha presentato la sua idea di ‘urban myth’, di mito urbano. Nel vostro lavoro, che ruolo ha avuto questa idea? Cos’è un ‘urban myth’?
Sì, l’idea che un’opera artistica possa creare un racconto, che si aggiunge come un oggetto malleabile al tessuto urbano, l’abbiamo presa in prestito da Francis Alÿs. Durante quella particolare performance in Perù, ‘When Faith Moves Mountains’, in cui cinquecento persone hanno spostato una duna di sabbia a colpi di pala, lui stesso ha distinto così narrazione, mitopoiesi e opera d’arte:
“Because of the immense amount of material produced on a daily basis by a huge city like Mexico City, it is very difficult to justify the act of adding another piece of matter to that already saturated environment. My reaction was to insert a story into the city rather than an object. ... If the story is right, if it hits a nerve, it can propagate like a rumour. If the script meets the expectation and addresses the anxieties of that society at the right time and place, it may become a story that survives the event itself. At that moment, it has the potential to become a fable or an urban myth”.
[Per via dell’immensa quantità di materiale prodotta ogni giorno in una città enorme come Città del Messico, è molto difficile giustificare l’atto stesso di aggiungere un nuovo elemento a un ambiente già così saturo. La mia reazione è stata quindi quella d’introdurre una storia nella città, piuttosto che un oggetto. …se la storia è buona, se tocca un nervo [scoperto], si diffonde proprio come un pettegolezzo. Se il suo racconto incontra le aspettative della società e parla alle [sue] ansie al momento e nel posto giusti, può diventare una storia che sopravvive alla sua stessa rappresentazione. In quel momento, quella stessa storia ha il potenziale per essere una fiaba, per diventare un mito urbano.]
I laboratori che stiamo facendo e che continueremo a fare nel corso del 2018 non creano, di fatto, un ‘urban myth’ nella città di Bologna – questo è però il desiderio che ci muove. Se tutto il percorso e la serie di documentari che faremo potrà aspirare a produrre qualcosa del genere, lo sapremo solo tra due anni, quando il film documentario sarà stato completato – quando verrà presentato pubblicamente negli stessi luoghi che ritrae, magari davanti a un pubblico che non ne ha mai sentito parlare.
Per esempio, lo sapevi che il grande lampadario a cerchi concentrici che abbiamo realizzato per il progetto di arte pubblica ‘ON. Luci di pubblica piazza’, che si trova oggi di fronte al cinema Lumière, è ispirato ai lampadari della Moschea Blu di Istanbul? Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, lo vede però come un tributo alle scenografie circensi del cinema di Federico Fellini… In questo caso, quindi, l’oggetto è diventato racconto, più racconti insieme. È un oggetto malleabile nel tessuto urbano, appunto, e ha anche un nome, si chiama ‘Casa Grande’. Nell’inverno tra il 2009 e il 2010 questo lampadario è stato appeso per tre mesi in piazza Verdi a Bologna, dove ha vegliato sulle notti di alcuni gruppetti di studenti seduti in cerchio sotto di lui, con il potere di domesticare un luogo frequentato e stra-usato da gruppi di persone tra i più diversi… melomani diretti a teatro, bambini diretti a scuola la mattina quando è ancora buio, commercianti di tutte le etnie e di tutte le merci, vagabondi, forze dell’ordine in divisa e in borghese, cani poliziotto e cani vagabondi attratti dagli stessi odori, residenti, turisti, laureandi e laureati, identità mutanti e oltre. Avrà certamente ispirato molte storie…

La relazione con ‘l’altro’ e con il territorio è un aspetto importante della vostra performance artistica. Come riuscite a crearla? Su quali princìpi si fonda?
Atlas of Transitions è un progetto che s’interroga sulle transizioni: movimenti, trasformazioni, migrazioni, mutamento d’identità, cittadinanza, futuro. Si misura con la paura, le tante paure che abbiamo. Paura di cambiare, dello sconosciuto, paura del futuro, paura che il futuro non esista, paura che la vita e la cultura non possano nulla contro l’economia, la finanza, l’impoverimento, la disumanizzazione. Ma la trasformazione della società non finirà mai. Un progetto come Atlas serve a nominare queste cose indicibili, a dare risposte che sono legate a questo preciso momento storico, quindi temporanee, e che sono in relazione con le diverse realtà vissute dai sette Paesi coinvolti nel progetto.
Affinché non sia la paura dello sconosciuto a dominare il nostro lavoro, il tema principale del documentario che stiamo progressivamente immaginando e realizzando è la riappropriazione del territorio, è la città stessa. È un approccio creativo e narrativo che cerca di smontare lo scenario di insicurezza che stiamo vivendo, e il primo termine a cadere è identità. La parola ‘identità’ è una trappola, una tautologia, perché non dice niente né di noi né dell’altro. Noi siamo molti… ognuno di noi non è espressione di una sola coscienza. Io [Anna], per esempio, ho varie voci che parlano in me, faccio parte di un corpo più grande o di più corpi – il corpo della mia famiglia allargata, il corpo dentro il quale sono cresciuta, il mio corpo invecchiato, il corpo delle mie simili, il corpo sociale, e se fossi musulmana, per esempio, sarei parte della Umma, il grande corpo-madre della comunità dei fedeli, quello che si contrae se anche solo una delle sue parti soffre.
Si tratta di capire quanto siamo parenti tra di noi, quali parti di noi formano alleanze con gli altri e quali invece entrano in conflitto, cosa possiamo scambiare, che lingua e che pratiche possiamo usare per esprimerci, per entrare in relazione e negoziare quello di cui tutti abbiamo bisogno: fiducia, riconoscimento. Ciò da cui non si può prescindere è l’ascolto dell’altro. Ascoltare prima di parlare, prima di agire, prima di filmare, ascoltare ancora prima di fare la prima domanda. Non solo ascoltare le persone, ma anche quello che condividiamo – lo spazio comune, il territorio in cui ci muoviamo. Stare l’uno davanti all’altra in silenzio, ad occhi chiusi. Ascoltare le ore 14.43, ascoltare la stanza, ascoltare la piazza.
In questa relazione con l'altro, quindi, che funzione ha il suono?
Fare un film documentario è un’operazione rischiosa, perché il risultato finale non è scritto in partenza. Un documentario si fa con quello che c’è, si media e si rimedia qualcosa che non è né la realtà né un’invenzione. Il suo stesso processo di creazione potrebbe essere considerato una performance collettiva. Il primo laboratorio fatto per Atlas, ‘Memoria Esterna’, concluso in dicembre [2017], è stato dedicato all’esplorazione del paesaggio sonoro nello spazio urbano attraverso alcune passeggiate per le strade di Bologna con un gruppo di circa 15 partecipanti di diverse nazionalità, tra i 16 e i 24 anni. Fare esperienza sonora è una pratica che usiamo da anni nel nostro lavoro, e serve a condividere un livello percettivo che viene normalmente considerato secondario rispetto alla vista. Allertare l’udito significa però vedere le cose in maniera diversa.
Durante il laboratorio ‘Memoria esterna’, l’unica indicazione che i partecipanti avevano era di stare in silenzio e in ascolto. Facendo così, e semplicemente camminando, il mondo ti viene incontro in modo diverso, nuovo. Per esempio, ci sembrava che le persone intorno a noi stessero seguendo una qualche partitura, come se fossero personaggi di una storia. Ovviamente erano solo passanti, ma questa percezione aumentata era sufficiente per immaginare una storia e avere poi il desiderio di raccontarla. Quindi, per rispondere alla tua domanda… noi entriamo in relazione con l’altro attraverso il racconto della nostra percezione del mondo. Durante i nostri incontri, il suono era il nostro strumento conoscitivo, la proposta che abbiamo fatto ad una quindicina di sconosciuti per farli diventare un gruppo che si muovesse in modo coordinato, ma senza sapere cosa sarebbe accaduto. Non occorre vedersi per sapere che siamo tutti qui…
Cosa hanno ‘scoperto’ i partecipanti a ‘Memoria Esterna’ durante la loro esplorazione sonora di Bologna?
Tanto per cominciare, Massimo ed io [Anna], non siamo di Bologna. Per noi questa è una città ancora da esplorare, anche attraverso la realizzazione di un film documentario. Bologna è la città di cui siamo diventati abitanti e cittadini, che abbiamo adottato come nostra. Quando torniamo a Bologna torniamo a casa. Anche per questo motivo, con i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio ‘Memoria Esterna’ non abbiamo cercato di produrre un oggetto artistico definito. Come dicevamo all’inizio, infatti, volevamo riappropriarci del territorio, e non rimuovere la paura di ciò che non conosciamo. Il risultato è stato che Bologna si è trasformata in un set inconsapevole, un playground con regole che la troupe dei partecipanti alle registrazioni sonore ha definito a poco a poco. Queste regole saranno poi comunicate, trasferite, al pubblico del film, che abita negli stessi luoghi del film, o in luoghi analoghi, o anche in territori diversi.
I partecipanti al laboratorio sapevano che non avremmo realizzato una fiction, che non ci sarebbe stato qualcuno a dire cosa doveva accadere… proprio perché la realtà non è già scritta, girare un documentario fa giustamente paura: tutti sono in disequilibrio, c’è tensione sia nel filmare sia nell’essere filmati, c’è il desiderio e la paura dell’altro. L’atto stesso di registrare, di riprendere, è un gesto palesemente fuori luogo, violento. Per ambientarsi in questo terreno scomodo è necessario fare alcune esperienze insieme ed essere tutti contemporaneamente spaesati. Poi succederà che alcuni agiranno come troupe, altri si ritroveranno sul set, poi forse accadrà il contrario.
I ragazzi, e noi con loro, hanno attraversato la città camminando uno dietro all’altro, in una fila che si è formata in modo casuale. Chi conduceva la nostra passeggiata sonora conosceva il percorso, gli altri, però, non sapevano dove stavamo andando. Seguire una guida ti solleva dal compito di anticipare i prossimi movimenti… così le persone che si lasciano guidare possono rimanere concentrate sulla loro camminata, sull’ascolto dei suoni, sulle loro percezioni. Crediamo che i partecipanti al laboratorio abbiano scoperto, prima di tutto, la pratica all’ascolto, che ne abbiano fatto esperienza e che l’abbiano interiorizzata come pratica creativa, la pratica con cui arricchire la loro conoscenza del posto in cui vivono, spalla a spalla con le persone che vivono gli stessi luoghi, anche se in modi tutti diversi.
Intervista – Francesca Di Renzo
Foto e audio – ZimmerFrei