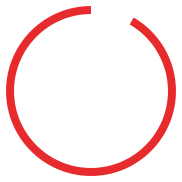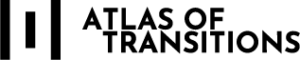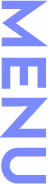Well-being o wall-being?
Confini e fabrica mundi
La vita fa presto a riformare dei vincoli che prendono il posto di quelli da cui ci si sente liberati: qualunque cosa si faccia e ovunque si vada, dei muri ci si levano intorno creati da noi, dapprima riparo e subito prigione.
(Marguerite Yourcenar, Archivi del nord, 1977)
Un vecchio proverbio inglese recita "Good Fences make Good Neighbors".
Non sono un fanatico dei muri, però in alcuni casi ne riconosco l’utilità.
Per quanto oggi venerata a dismisura, la proprietà privata - supporto inalienabile di diritti individuali - ha contribuito a modellare la modernità, pacificare guerre tra stati, difendere i cittadini dai tiranni di turno. Ma il muro, che spesso la delimita, è un oggetto ambivalente: protegge e divide, difende e separa.
Osservando le crepe delle fortezze, in primis quella europea (che assomiglia più a un club molto esclusivo che non a una vera e propria fortezza) vediamo come, attraverso i muri, legittime realtà opposte si confrontano. Mentre neoliberisti, cosmopoliti, umanitari e attivisti transnazionali sognano un mondo senza frontiere (che sia a misura dei mercati globali o della cittadinanza/governance globale), gli Stati-nazione, ricchi e poveri, manifestano una vera e propria passione per la costruzione di muri.
Per quanto impossibile stilare un elenco completo dei muri innalzati dal secondo dopoguerra ad oggi, basti pensare al famigerato muro che per oltre tre decenni ha diviso la Berlino del blocco sovietico da quella occidentale, al muro che delinea il confine tra le due Coree, quello tra Marocco e profughi Saharawi accampati nel deserto algerino, quello che divide ciprioti e greci ormai divenuto anacronistico per le nuove generazioni, i muri della pace che in Irlanda del nord testimoniano la lotta trentennale tra la comunità unionista protestante e la comunità repubblicana cattolica, la linea che divide India e Pakistan nella regione contesa del Kashmir, la barriera eretta dagli Stati Uniti per arginare l’immigrazione illegale dal Messico, il muro tra Myanmar e Bangladesh che circonda la regione in cui risiede la minoranza Rohingya, quello tra Sudafrica e Mozambico, sino a quelli più recenti tra l’Arabia Saudita e lo Yemen o l’Iraq, tra l’India e i diversi ‘stan’ confinanti. E ancora la recinzione elettrificata che separa il Botswana dallo Zimbabwe, la barriera in cemento e acciaio che divide la Thailandia dalla Malaysia, quella che tra Iran e Pakistan separa la comunità balucha, la barriera che divide sciiti e sunniti a Baghdad, le tante barriere solide e liquide che impediscono a milioni di profughi di richiedere asilo in Europa, sino al muro della vergogna che manifesta la presenza violenta di Israele nei Territori Palestinesi.
Edificati per bloccare lavoratori o profughi, terrorismo o droghe, armi o merci di contrabbando, promiscuità etnica o religiosa, queste fortificazioni rudimentali o dotate di alta tecnologia sono meno significanti nella loro materialità e fisicità rispetto alle narrazioni ideologiche che in esse si sedimentano.
Più che vestigia vestfaliane o scudi contro nemici esterni, i muri oggi appaiono marcatori di una geografia morale del mondo in cui convive apertura e chiusura, universalizzazione e esclusione. Segni concreti dei paradossi di una globalizzazione solitamente identificata nei suoi elementi più immateriali, flussi elettronici e finanziari, ma che ha nella localizzazione l’altra faccia della medaglia.
 Foto di Bruna Di Palma - con-fine edizioni
Foto di Bruna Di Palma - con-fine edizioni
Se, infatti, lo sviluppo capitalistico storicamente esprime una tensione verso il superamento dei muri o, meglio, verso l’annientamento dello spazio mediante il tempo, a questo fa da contraltare un ancoraggio al locale, oggi esperito come sintomo di inferiorità e degradazione sociale. La compressione spazio-temporale che fa del mondo un ‘villaggio globale’ ha esautorato lo Stato della sua reale capacità di controllo sulle dinamiche politiche, sociali ed economiche al suo interno, sino a renderlo non più ‘sovrano’ come lo aveva immaginato Thomas Hobbes nel Leviatano e, in seguito, Rousseau, Bodin o Carl Schmitt.
D’altra parte, con il motto ‘meno stato nell’economia meglio è’, dai tempi di Margaret Thatcher e Ronald Reagan, conservatori o progressisti, europei o statunitensi, i governi hanno agito tutti verso la stessa direzione: smantellare il sistema di welfare a protezione delle fasce più deboli e privatizzare i servizi pubblici.
Così la politica nazionale, svuotata delle conquiste democratiche tipiche del ‘progetto della modernità’, si è ritrovata a dover gestire il gap fra gli individui ‘nazionalizzati’ (il cui status è ancora inquadrato da passaporti, visti, residenza, cittadinanza, ecc.) e questioni che diventano sempre più globali, davanti alle quali i primi non hanno quasi nessuna voce in capitolo.
Gap che emerge con forza proprio nell’ambito delle politiche in materie di visti, controllo delle frontiere e immigrazione: settori in cui lo stato ha ancora ampio margine di manovra. Un potere che spesso si estrinseca nelle funzioni di polizia e controllo del territorio, reso più urgente dall’esigenza di affrontare la sfida del crimine e del terrorismo transnazionale, e nella gestione delle reazioni dei propri cittadini a questo processo di espropriazione della sovranità popolare: sentimenti di malcontento, alienazione, rabbia, che spesso diventano proteste violente rivolte verso quanti cittadini non sono.
E allora si innalzano muri, tangibili icone di una debolezza e di una vulnerabilità con cui gli Stati non avevano ancora avuto modo di confrontarsi. Rappresentando simbolicamente una funzione ed un’efficacia che in realtà non esercitano, tali muri - come scrive Wendy Brown - appaiono come una “performance teatrale e spettacolarizzata del potere”. Una performance che rispecchia il potere produttivo del confine, ovvero il ruolo strategico che esso gioca come fabrica mundi, la sua capacità di costruire il mondo. E lo vediamo nelle linee rigide di ogni mappa geografica che certifica violenza e soprusi. Così come nelle narrazioni securitarie o umanitarie che spettacolarizzano le operazioni di controllo o salvataggio in un Mediterraneo che, pur nella sua liquidità, rappresenta un muro cognitivo, morale, politico.
Per quanto teorizzato fin dal XVIII secolo da filosofi e giuristi internazionali (Grozio, Locke, Voltaire, Kant), il diritto di migrare è uno dei diritti meno equamente distribuiti tra le diverse zone del mondo. Un diritto che si è spostato dal divieto di uscita che caratterizzava i regimi nazi-fascisti e il blocco comunista del passato (e dunque caduto con il muro di Berlino a partire dal 1989) al divieto di entrata in un altro paese, oggi vigente nella maggior parte degli stati ricchi, dall’Europa agli Stati Uniti, all’Australia.
La crisi dello Stato-nazione tenta di nascondersi dietro muri che promettono di difendere i cittadini dai pericoli esterni, ma che sembrano più utili a distogliere l’attenzione dalla crisi, dall’erosione di diritti che diventano privilegi.
Muri come desiderio di sigillarsi da un fuori pericoloso, distanziarsi dalla vulnerabilità, difendere la nostalgia di un passato coloniale o l’illusione di un futuro migliore, e sviare così il risentimento verso le crescenti disuguaglianze interne, che ci fan sentire sempre più inadeguati e soli nella nostra incapacità di affrontare le performances richieste dal capitalismo globale.
Un wall-being edificato sulle macerie del well-being, come il "muro di via Anelli" costruito nel 2006 a Padova per dividere il quartiere abitato da immigrati dalle villette a schiera dei veneti, o la "Grande Muraglia di Calais" costruita nel 2016 per impedire ai migranti di salire clandestinamente sui camion diretti in Gran Bretagna.
Il muro più inamovibile diventa dunque quell’incertezza esistenziale che ci espone al rischio di emarginazione sociale. Un muro che dentro erode la nostra autostima e fuori la nostra libertà di movimento, da sempre una merce scarsa e distribuita in maniera ineguale.
Se focalizziamo la relazione spazio-tempo vediamo che è oggi la stratificazione sociale, più che 20.000 km di muri, a creare un mondo a vivibilità limitata per quanti sono interdetti dalle leggi sull’immigrazione, dai quartieri delle metropoli a controllo elettronico, dalla “tolleranza zero”.
Il contrarsi dello spazio abolisce il fluire del tempo e crea una sorta di muro sanitario che sembra dividere gli abitanti della parte ‘alta’ del mondo - che vivono immersi in una sequenza di eventi, in un perpetuo presente -, e i residenti della parte bassa, ancorati allo spazio e a un tempo dove non succede mai niente, vuoto, lento, da ammazzare, fino a restarne lentamente uccisi.
L’esplicitazione delle conseguenze della globalizzazione sulle persone consiste – sostiene Bauman - nella divisione tra “turisti” e “vagabondi”, con questi ultimi che hanno, come unico sogno, quello di essere turisti, di entrare a far parte dell’élite del consumo accessibile e dell’extraterritorialità. Turista e vagabondo sono uno l’alter ego dell’altro, con la differenza che il vagabondo è legato con catene doppie alla territorialità, umiliato dall’obbligo di dover restare fermo, a fronte dell'ostentata libertà di movimento degli altri.
Se il vagabondo invidia la vita del turista e vi aspira, a sua volta il turista, nella sua fascia media, ha il terrore che il suo status possa cambiare all’improvviso. Per questo il vagabondo è l’incubo del turista, che percepisce in esso il rischio della precarietà e l’odore amaro della sconfitta. Il muro diventa allora uno strumento per bandire il mendicante e il barbone dalla strada, i migranti, gli sfollati, i richiedenti asilo, confinandoli in lontani ghetti dove non si va, chiedendone l’esclusione, l’esilio o l’incarcerazione. Rendendoli spesso morti senza nome nel tentativo disperato di cancellare le proprie paure. Vite ‘non degne di lutto’ le definisce Judith Butler.
Per tornare al vecchio proverbio inglese, sarebbe dunque opportuno ripensare il significato, il ruolo dei muri e dei confini oggi, chiederci come questi possano ancora essere ‘buoni da pensare’ e ‘buoni per vivere’.
Potremmo ad esempio iniziare a distinguere tra muro, segno tangibile di reciproca chiusura, e confine, al contempo limite e passaggio. E tener conto che il muro sta al confine come l’identità sta all’alterità. Vedremmo che il conflitto bifronte tra muro e confine rispecchia quello tra l’ossessione per l’identità e la relazione come apertura all’altro.
Ci renderemmo forse conto che, seppur instancabili e ostinati produttori di muri anche internamente, siamo cosmopoliti di fatto perché viviamo tutti e in ogni momento attraversando confini e soglie, paesaggi liminali, ‘borderlands’. In un mondo che assume sempre più le sembianze di un labirinto dovremmo decostruire i muri e ripensare i confini come luoghi, situazioni o momenti che ritualizzano la relazione con l’altro, rinnovando continuamente la logica amico-nemico, categorizzando lo straniero come alieno pericoloso o vittima da compatire.
Oltre il muro, potremmo vivere il confine come quel limen dove due differenze si toccano, esperiscono la propria limitatezza, si confrontano, riconoscono, arricchiscono a vicenda. E leggere nell’elenco sempre incompleto dei muri contemporanei la materializzazione di una chiusura identitaria che porta alla scomparsa dell’altro, alla sparizione di quell’alterità senza la quale le identità non hanno più un’esistenza sociale.
Bibliografia essenziale
Agier, M. (2016), Borderlands: Towards an Anthropology of the Cosmopolitan Condition, Polity Press, London.
Brown ,W. (2013), Stati murati, sovranità in declino, Roma-Bari, Laterza, 2013.
Bauman, Z. (2002), Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari.
Butler J. (2013), A chi spetta una buona vita?, Roma, Nottetempo
Cassano F. (2007), Il pensiero Meridiano, Laterza, Roma-Bari.
Cuttitta, P. (2012), Lo spettacolo del confine, Mimesis, Milano-Udine
Mezzadra, S., Neilson, B. (2014), Confini e Frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale, il Mulino, Bologna.
Musarò, P. (2016), Mare Nostrum: the visual politics of a military-humanitarian operation in the Mediterranean Sea, in «Media, Culture & Society», 39 (1), pp. 11-28.
Da The WALL book, a cura di Claudio Mazzanti
con la collaborazione di Andrea Maioli,
con-fine edizioni,
Monghidoro (BO), Italia -2018